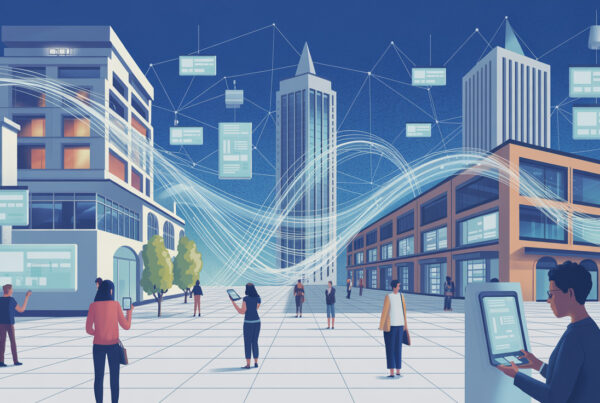Basta carta! Il presidio della gestione documentale
Una riflessione introduttiva di Mariella Guercio
La funzione di organizzazione e gestione dei documenti ha avuto sin dalle origini il fine di assicurare alle attività umane un supporto stabile di memoria, immodificabile e ben organizzato, in grado di fornire testimonianza, affidabile e verificabile anche a distanza di tempo, di quegli eventi e di quegli atti di cui i documenti costituiscono la rappresentazione.
Questa funzione documentaria risponde all’esigenza di offrire certezza a quelle relazioni e a quei comportamenti che hanno conseguenze giuridiche, documentando attività e decisioni di una persona fisica o di un ente (pubblico o privato). I documenti prodotti nell’esercizio di queste attività costituiscono l’archivio, la sedimentazione di memoria stabile e persistente della persona o dell’ente.
La crescita di numero, ruolo e dimensioni degli apparati pubblici nel corso dei secoli e soprattutto nel mondo contemporaneo ha determinato l’aumento della produzione documentaria e ha richiesto regole e strumenti per la gestione documentale capaci di guidare con efficienza ed efficacia la formazione, il trattamento, il recupero e la conservazione dei documenti, proteggendone l’autenticità nel tempo. Si devono oggi gestire quantità crescenti di informazioni e soprattutto molteplici e diverse tipologie di documenti e di aggregazioni in un contesto reso ancora più dinamico, ricco e frammentario dalla trasformazione digitale.
Il modello tradizionale di organizzazione e dell’archivio è articolato in fasi di gestione (corrente, di deposito e storica) ed è stato finora funzionale soprattutto al trattamento dei patrimoni documentari analogici.
Le fasi sono distinte ma integrate, e in ciascuna prevale una dimensione dell’archivio: pratico-giuridica, di supporto informativo (nell’archivio corrente), probatoria, di testimonianza a fini legali (nell’archivio di deposito), culturale e informativa a fini generali di ricerca (nell’archivio storico).
La fase corrente – quella che coincide in larga parte con la funzione di gestione documentale – è fondamentale nelle organizzazioni per presidiare la qualità della memoria documentaria a fini di trasparenza e gestione ma anche per la salvaguardia del futuro patrimonio storico.
In questa fase iniziale si definiscono e applicano i principi e gli strumenti che costituiscono la funzione di gestione documentale, cioè il controllo generale e sistematico su tutti i documenti prodotti e ricevuti dall’organizzazione.
In questa fase si adottano gli strumenti e si regolano i comportamenti necessari per identificare con certezza e organizzare con efficacia i documenti ricevuti e prodotti in raggruppamenti funzionali al fine di renderli accessibili e a mantenerli integri e autentici.
Gli strumenti e le regole sono al servizio del valore legale e probatorio di qualunque tipo di documento, ma sono soprattutto indispensabili per i documenti informatici che sono, per la loro natura specifica, a maggior rischio di obsolescenza, di dispersione e di modifiche non autorizzate.
Possiamo quindi ritenere che, anche nella dimensione digitale ormai prevalente, anzi pervasiva e sostitutiva di quella analogica, la funzione documentale costituisca un presidio imprescindibile per l’efficacia dell’azione amministrativa o tecnica e per la salvaguardia dei diritti dei cittadini e della trasparenza, oltre che della memoria futura? Le argomentazioni a favore di una risposta positiva a questo interrogativo non mancano. Proviamo ad elencarle:
- Attraverso il sistema di gestione documentale informatica si organizzano i documenti informatici e si crea l’archivio informatico dell’ente: si individuano gli elementi informativi (metadati) che identificano il documento e le sue relazioni. Le attività costitutive tradizionali della gestione documentale (la registrazione, la classificazione e la formazione delle aggregazioni documentarie) non solo non perdono significato nel mondo digitale ma accrescono il loro peso di ancoraggio e di consolidamento di una sedimentazione di informazioni e di documenti le cui dimensioni sono da decenni ormai in crescita esponenziale.
- La gestione documentale (inclusiva anche delle attività di tenuta/archiviazione dei documenti) consente di rispondere con efficacia all’esigenza primaria di formare e gestire con coerenza e qualità i documenti informatici e le copie digitali degli originali analogici e di mantenere nel tempo la capacità probatoria dei documenti, perché – grazie agli elementi obbligatori della registrazione di protocollo e della segnatura, ma anche attraverso la repertoriazione – assicura:
- la identificazione e gestione della provenienza (CHI) garantendo l’imputabilità nel tempo del contenuto al suo autore dato che le registrazioni di protocollo sono a conservazione illimitata;
- la gestione e verifica dell’integrità del contenuto e delle altre componenti costitutive (CHE COSA), dato che l’impronta che identifica con certezza il contenuto del documento è un elemento obbligatorio del protocollo);
- la validazione temporale opponibile a terzi (QUANDO) mediante la registrazione (segnatura di protocollo, poiché è gratuita e persistente nel tempo.
- Anche gli strumenti messi a disposizione dalla funzione documentale (classificazione, piano di formazione dei fascicoli e delle serie, piano di conservazione e manuale di gestione) accompagnano e sostengono gli interventi di pianificazione dei processi di lavoro sempre più granulari e dinamici della trasformazione digitale, in quanto sviluppati e gestiti da un servizio unitario affidato a una figura con competenze archivistiche, giuridiche, informatiche, cui sono affidati compiti di normalizzazione nella formazione dei documenti informatici dell’ente e nella loro organizzazione sistematica.
- L’ottimizzazione funzionale della sedimentazione documentaria è garantita dalla presenza di piani e regole che mettono in relazione la gestione dei flussi e la produzione e conservazione ordinata dei documenti.
Potremmo continuare a elencare i vantaggi di una gestione documentale, correttamente pianificata e implementata. Tuttavia, la risposta più efficace è sempre legata all’esperienza concreta e alle quotidiane difficoltà – talvolta gravide di conseguenze – che sperimentiamo quando la cura dei documenti informatici è trascurata e la loro organizzazione lasciata alla discrezionalità dei singoli operatori.