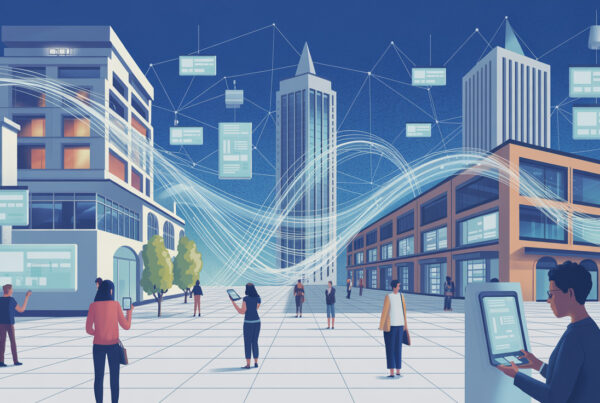Gli strumenti che governano il vincolo archivistico nel sistema di gestione documentale sono il piano di classificazione e il piano di organizzazione delle aggregazioni documentale: il primo è il risultato di attività consolidate nella tradizione archivistica italiana e internazionale, il secondo è stato introdotto nel nostro ordinamento dalle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informati adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale nel 2021 e divenute operative nel 2022.
Entrambi i piani rispondono alla necessità di gestire le relazioni documentarie e hanno lo scopo di formare l’archivio rispettando la natura e il ruolo dei documenti e dei processi di lavoro, tenendo conto delle esigenze di chi lavora e trasformando il flusso informativo in aggregazioni di documenti (serie e fascicoli) che rispecchiano le funzioni che l’ente svolge e che sono definite nel piano di classificazione. Grazie a questi due strumenti l’archivio svolge con efficienza compiti di trasparenza, di testimonianza, di rendicontazione.
Senza queste attività i documenti perdono gran parte del loro valore poiché i collegamenti sono limitati alla singola transazione. La classificazione fornisce all’ente il quadro delle funzioni e delle attività per l’esercizio del suo mandato. Operativamente, come è noto, tutti i documenti utili al lavoro amministrativo o tecnico sono identificati con lo stesso indice di classificazione (cioè il codice alfanumerico che rappresenta le partizioni del piano di classificazione o titolario). Perché lo strumento dia i risultati attesi, è indispensabile che
- sia unitario e applicato da tutti a tutto l’ente secondo regole ben definite,
- sia fondato su principi di uniformità ricostruibili e conosciuti dai dipendenti,
- sia in grado di guidare la sedimentazione dei documenti facilitando la futura ricerca per qualunque di utente.
La classificazione non è sostituibile da generiche attività di indicizzazione, poiché non si limita a sostenere la ricerca dei documenti ma guida le attività di ordinamento e indirizza le successive attività di creazione delle aggregazioni dei documenti. Poiché ogni documento deve essere ricondotto a una partizione del titolario, non possono esistere in un sistema documentale correttamente gestito documenti non classificati.
La normalizzazione e la qualità dell’archivio non sono tuttavia garantite se la classificazione non è integrata anche da indicazioni specifiche e coerenti, concrete e di facile applicazione, finalizzate a guidare con la necessaria flessibilità la formazione dei fascicoli e delle altre aggregazioni archivistiche (serie, sotto-serie, sotto-fascicoli). A questo compito è dedicato il piano di organizzazione delle aggregazioni documentarie che include indicazioni finalizzate a guidare, per ciascuna partizione del piano di classificazione, la sedimentazione dei documenti tenendo conto delle tipologie di aggregazione (fascicolo di attività, di affare o di procedimento, serie di documenti accorpati per tipologia e forma).
Si tratta di attività impegnative sia nella fase di progettazione e realizzazione degli strumenti, sia nella loro quotidiana applicazione, poiché richiedono agli operatori la conoscenza dell’ente e delle sue funzioni e una costante attenzione nel loro esercizio. I vantaggi sono tuttavia innegabili, consentendo di
- organizzare la documentazione con criteri stabili e uniformi nel tempo,
- evitare l’archiviazione discrezionale del fai da te,
- facilitare la ricerca e la fruizione,
- collegare le diverse sezioni del patrimonio documentario anche se risiedono in spazi e dispositivi diversi, digitali e analogici,
- sostenere concretamente le attività di selezione e scarto,
- favorire il coinvolgimento del personale nella costruzione del sistema informativo dell’ente,
- individuare responsabilità per la gestione dei documenti e per la continuità amministrativa.
La difficoltà maggiore, anche per la novità dello strumento e la sostanziale assenza di buone pratiche, riguarda la guida alla formazione dei fascicoli che richiede l’acquisizione e il trattamento di informazioni su cui si è raramente concentrata l’attenzione degli stessi archivisti, come nel caso dei collegamenti tra fascicoli complementari, di indicazioni operative per l’uniformazione delle intitolazioni dei fascicoli medesimi (nella denominazione delle aggregazioni ma anche – se opportuno – nella definizione dei contenuti standard, della loro articolazione interna e dei tempi di chiusura) o dell’individuazione di responsabilità specifiche nella gestione delle aggregazioni.
Perché queste attività abbiano successo è, inoltre, indispensabile che
- i piani siano comprensibili e di facile applicazione,
- le descrizioni e le istruzioni siano complete, ma non inutilmente sovrabbondanti,
- l’uso degli strumenti sia monitorato e il loro aggiornamento costantemente assicurato.
Il piano triennale per la trasformazione digitale della PA prevede un primo monitoraggio sull’esistenza degli strumenti citati che Agid ha il compito di concludere entro il 31 dicembre 2025. Poiché si tratta di attività impossibili da improvvisare in pochi mesi e tenuto conto che gran parte delle amministrazioni pubbliche non dispone di figure professionali competenti in questo settore, nonostante gli obblighi stabiliti dal legislatore più di vent’anni fa, è facile immaginare che nel corso dell’anno che sta per concludersi, le difficoltà siano spesso affrontate con operazioni di facciata. Merita tuttavia sottolineare che il questionario di rilevamento degli adempimenti include una decina di domande puntuali, da un lato destinate comunque a richiamare l’attenzione degli enti sulle loro responsabilità, dall’altro in grado di fornire le basi per valutare lo stato dell’arte e promuovere azioni efficaci di salvaguardia affinché la trasformazione digitale non implichi la perdita degli strumenti indispensabili a interrogare e conservare in modo appropriato l’enorme mole di documentazione che stiamo accumulando.